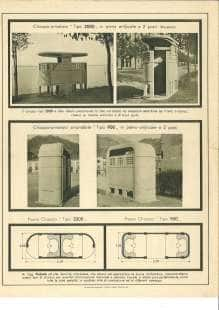EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA, UN RITORNO INDISPENSABILE, di Ferruccio De Bortoli
Pubblicato il 13 gennaio, 2019 in Il territorio | Nessun commento »
Tema: la reintroduzione dell’Educazione civica come materia «con voto autonomo nei curricula scolastici di ogni ordine e grado». In realtà, in sei mesi di raccolta, i firmatari sono stati 83.326, di cui 27.261 in Lombardia, 15.508 in Toscana e 10.261 in Emilia e Romagna. Si sono mobilitati circa duemila Comuni, con amministrazioni di tutti gli orientamenti; 27 associazioni, dalle Acli alla Legambiente a Sant’Egidio; 24 testimonial, da Gigi Proietti a Liliana Segre.
La maggioranza gialloverde ha l’opportunità di dimostrarsi sensibile alle istanze del territorio e delle associazioni. Insomma, del popolo. E sarebbe un indiscutibile cambiamento se, cosa mai accaduta, fosse approvata una legge di iniziativa popolare in questa materia. Si applicherebbe l’articolo 71 della Costituzione, in un suo comma un po’ sterile. Una medaglia per il «governo del cambiamento». «Noi l’abbiamo fatto e voi in tanti anni no». Slogan efficace. E poi su un tema così centrale per la qualità della democrazia del nostro Paese come l’educazione alla cittadinanza. Se si continua a dire, anche a sproposito, «prima gli italiani», bene preoccupiamoci anche della loro formazione, della coscienza civica, del senso della legalità. E del grado di cittadinanza degli immigrati di seconda generazione.
La proposta dei Comuni, sostenuta fortemente dall’Anci, l’Associazione che li riunisce, mette insieme per la verità un po’ troppe cose. Dalla conoscenza della nostra Costituzione alla cultura della memoria, alla lotta contro il cyberbullismo, la volgarità in Rete e gli sprechi alimentari, alla tutela dell’ambiente. Ma le intenzioni sono lodevoli e colpisce che se ne parli così poco. Dobbiamo stupirci? Forse no, visto il degrado del nostro discorso pubblico e le immagini di ordinaria e popolare inciviltà.
In materia di educazione civica, sono state già presentate in Parlamento dieci proposte, da gruppi di vario orientamento. Tra queste, anche quella (primo firmatario Massimiliano Capitanio) della Lega per la reintroduzione dell’insegnamento, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Fu Aldo Moro, ministro della Pubblica istruzione, a introdurre l’Educazione civica come materia nel 1958. Le lezioni venivano impartite dagli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia alle medie. Negli anni 90 la materia era già sparita. Con la legge 169 del 2008, l’allora ministra Mariastella Gelmini, raccomandava l’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. Una materia un po’ di tutti e di nessuno. Presidi e professori si sono arrangiati, con tante autonome e originali iniziative. «Ma un tema così rilevante — spiega Fulvio Cortese, docente di Istituzioni di diritto pubblico a Trento, università nella quale ha studiato lo stesso Fraccaro — non può essere lasciato alla sola buona volontà del corpo insegnante. Esistono casi virtuosi, ma in generale più che istruire si sensibilizza. E la Costituzione magari si difende ma non si insegna. L’Educazione civica non deve però diventare un contenitore ibrido, con dentro tutto, dalla disciplina alimentare all’uso delle tecnologie. Né presentarla agli studenti come qualcosa di noioso e obbligato, con banalizzazioni e inutili nozionismi. E poi, parliamoci chiaro, bene l’Educazione civica a scuola, ma poi contano gli esempi nella vita di ogni giorno». E i pessimi esempi — scarso rispetto delle regole, del bene comune — abbondano. Così i cattivi maestri. Soprattutto in Rete. La proposta di legge di iniziativa popolare sull’Educazione civica — che ci auguriamo venga discussa e approvata dalle Camere — ha un solo grande difetto. Non riguarda gli adulti. Ferruccio De Bortoli, Il Corriere della Sera, 13 gennaio 2019
La proposta dei Comuni, sostenuta fortemente dall’Anci, l’Associazione che li riunisce, mette insieme per la verità un po’ troppe cose. Dalla conoscenza della nostra Costituzione alla cultura della memoria, alla lotta contro il cyberbullismo, la volgarità in Rete e gli sprechi alimentari, alla tutela dell’ambiente. Ma le intenzioni sono lodevoli e colpisce che se ne parli così poco. Dobbiamo stupirci? Forse no, visto il degrado del nostro discorso pubblico e le immagini di ordinaria e popolare inciviltà.
In materia di educazione civica, sono state già presentate in Parlamento dieci proposte, da gruppi di vario orientamento. Tra queste, anche quella (primo firmatario Massimiliano Capitanio) della Lega per la reintroduzione dell’insegnamento, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Fu Aldo Moro, ministro della Pubblica istruzione, a introdurre l’Educazione civica come materia nel 1958. Le lezioni venivano impartite dagli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia alle medie. Negli anni 90 la materia era già sparita. Con la legge 169 del 2008, l’allora ministra Mariastella Gelmini, raccomandava l’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione. Una materia un po’ di tutti e di nessuno. Presidi e professori si sono arrangiati, con tante autonome e originali iniziative. «Ma un tema così rilevante — spiega Fulvio Cortese, docente di Istituzioni di diritto pubblico a Trento, università nella quale ha studiato lo stesso Fraccaro — non può essere lasciato alla sola buona volontà del corpo insegnante. Esistono casi virtuosi, ma in generale più che istruire si sensibilizza. E la Costituzione magari si difende ma non si insegna. L’Educazione civica non deve però diventare un contenitore ibrido, con dentro tutto, dalla disciplina alimentare all’uso delle tecnologie. Né presentarla agli studenti come qualcosa di noioso e obbligato, con banalizzazioni e inutili nozionismi. E poi, parliamoci chiaro, bene l’Educazione civica a scuola, ma poi contano gli esempi nella vita di ogni giorno». E i pessimi esempi — scarso rispetto delle regole, del bene comune — abbondano. Così i cattivi maestri. Soprattutto in Rete. La proposta di legge di iniziativa popolare sull’Educazione civica — che ci auguriamo venga discussa e approvata dalle Camere — ha un solo grande difetto. Non riguarda gli adulti. Ferruccio De Bortoli, Il Corriere della Sera, 13 gennaio 2019